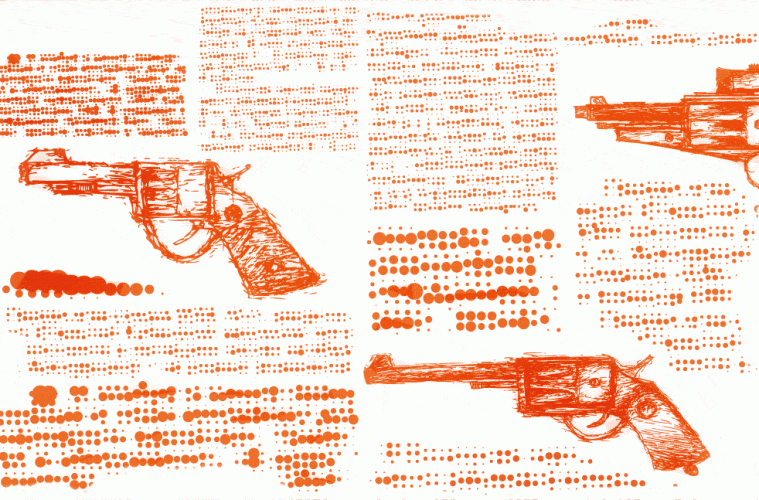La condizione era ideale. Pioveva e quasi tutti avevano l’ombrello aperto, il che impediva agli altri di vedermi bene in faccia.
Io tenevo il mio abbassato in avanti per coprirmi il volto. Mi trovavo a un centinaio di metri da un palazzo di quattro piani che si affacciava su una piazza deserta. Ero arrivato poco prima delle sette del mattino. L’uomo che aspettavo sarebbe presto uscito di casa per salire sulla sua automobile, una Fiat 1100 grigia parcheggiata a pochi metri di distanza su via Buonriposo.
Avevo la pistola in pugno. Il cane dell’arma, una Taurus a tamburo di fabbricazione brasiliana con sei colpi, era già alzato e Pindice era sul grilletto. Tremavo come una foglia. Avevo fatto le prove sparando una decina di volte in una zona di campagna nella Piana dei Colli, a nord di Palermo. A ogni colpo la rinculata mi spostava di fianco.
La pistola, vecchissima ma efficiente, era di mio nonno, che la custodiva da oltre vent’anni in un buco nel muro sopra una delle finestre di casa sua, insieme a una cassettina di legno impermeabilizzata con oltre 60 proiettili.
Certo, avrei potuto procurarmi un’arma più moderna ed efiiciente rivolgendomi a uno dei tanti amici che sbarcavano il lunario con scippi e rapine. Qualche volta prendevano «in affitto» le pistole da altri disperati e le restituivano con un lauto compenso se il colpo era andato a buon fine. Ma era molto pericoloso: avrei lasciato tracce e avrei dovuto fornire spiegazioni. Non potevo dire al mio fornitore che la pistola mi serviva per compiere un omicidio. Non me l’avrebbe data. Fîno a quando si trattava di furti o rapine era facile farla franca, a meno che non ci fosse una soffiata. Ma su un morto ammazzato polizia e carabinieri avrebbero indagato a fondo.
Era il 26 marzo 1966, avevo compiuto da poco diciassette anni ed ero li in via Buonriposo con quel ferrovecchio in mano per uccidere l’uomo che nel 1950 aveva ammazzato mio padre, lasciandomi orfano a tredici mesi. Avevo studiato il mio «bersaglio» per giorni. Era un uomo sui quarant’anni, sempre vestito con lo stesso completo marrone. Avevo seguito ogni suo spostamento, sapevo quando usciva di casa e quando rientrava. Ora si trovava a due metri da me e mi dava le spalle. Camminava lentamente, tenendo in braccio un bambino di un anno o poco più che mi guardava con curiosità oltre la sua spalla, fissando la mia mano che impugnava la pistola. Non sapeva che stavo per uccidere suo padre.
Pagina tratta da “Io, killer mancato: Il giornalista cresciuto con i mafiosi” Autore: Francesco Viviano Editore: Chiarelettere Acquista il libro
“Io, killer mancato” è la storia di Francesco Viviano, cresciuto tra i mafiosi e diventato uno dei più importanti inviati italiani. È la storia di un ragazzo che ce l’ha fatta. Che non si arrende ai soldi facili, che non cede alla vendetta: non vuole fare come i suoi amici e diventare il braccio destro dei boss della Piana dei Colli. Cameriere, marmista, pellicciaio, muratore, commesso. Poi la svolta, fattorino e telescriventista per l’Ansa, quindi giornalista. Prima all’Ansa, poi a “la Repubblica”. È qui che Francesco Viviano tira fuori tutto quello che ha imparato tra i vicoli di Palermo, perché lui sa come muoversi e dove trovare le notizie, sa con chi deve parlare e come farlo. Attraverso il suo sguardo, il lettore rivive gli anni folli delle guerre di mafia, il maxiprocesso nell’aula bunker dell’Ucciardone, gli omicidi Falcone e Borsellino, le grandi confessioni dei pentiti, l’arresto di Brusca, la caccia al papello di Riina, le prime rivelazioni sulla trattativa tra mafia e Stato. “Io, killer mancato” è anche la storia dell’amicizia con Peppe D’Avanzo, Mario Francese e Attilio Bolzoni, di coloro che hanno fatto giornalismo cercando insieme gli scoop o strappandoseli di mano… Prefazione di Attilio Bolzoni.